Etichetta: CONTRARRE
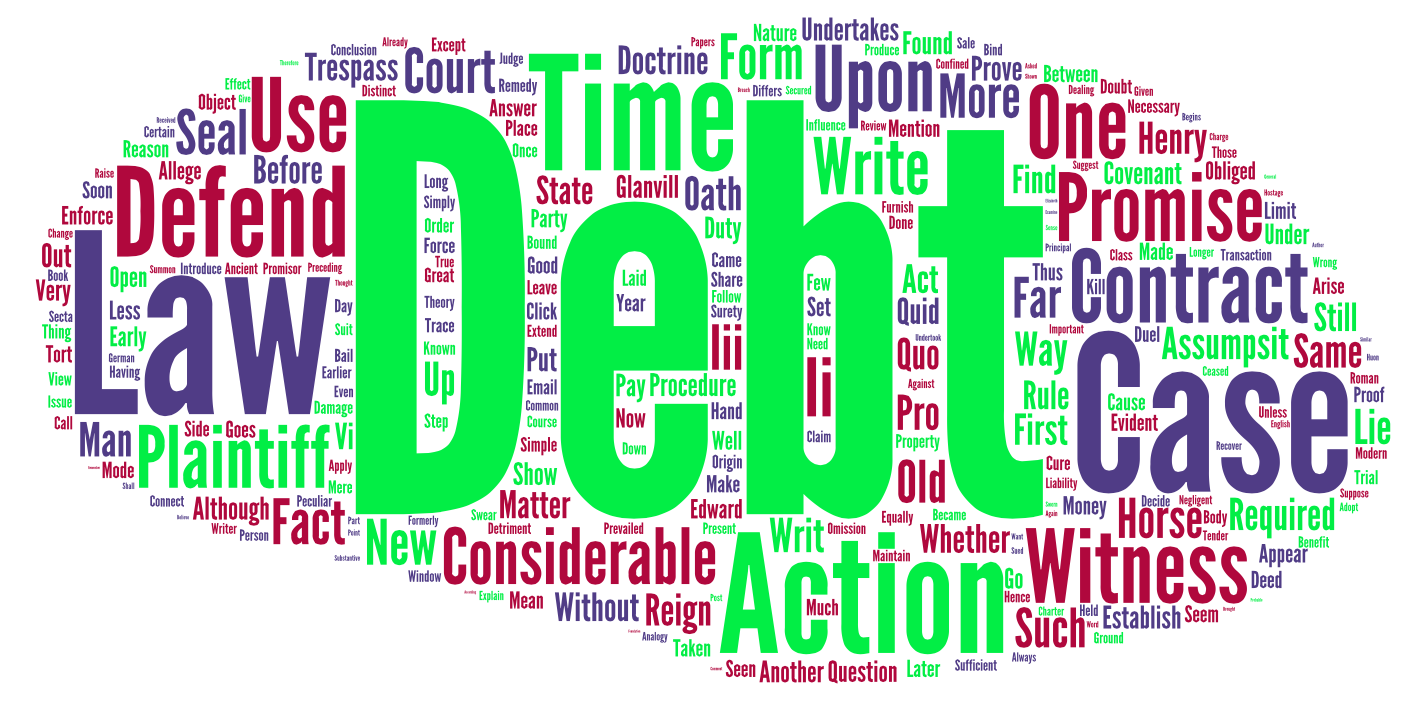
CONTRATTO. — I. STORIA.
Di Oliver Wendell Holmes, Jr.
La dottrina del contratto è stata così profondamente rimodellata per soddisfare le esigenze dei tempi moderni, che qui c'è meno che altrove per la ricerca storica. È stato discusso in modo così abile che altrove c'è meno spazio per analisi essenzialmente nuove. Ma a breve della crescita delle dottrine moderne, se necessario o no, sarà almeno interessante, mentre non si può omettere un'analisi delle loro caratteristiche principali, e potrebbe presentare alcune nuove funzionalità.
Si suppone comunemente che le più antiche forme di contratto conosciute dalla nostra legge siano il patto e il debito, e sono di data anticipata, senza dubbio. Ma ci sono altri contratti ancora in uso che, sebbene abbiano in una certa misura messo su forme moderne, almeno suggerisci la domanda se non fossero di apparizione altrettanto precoce.
Uno di questi, il giuramento, non è più fondamento di alcun diritto di diritto privato. È solito, ma soprattutto come solennità connessa con l'ingresso in un pubblico ufficio. Il giudice giura che farà giustizia secondo la legge, il giurato che troverà il suo verdetto secondo la legge e le prove, il cittadino appena adottato che porterà vera fede e fedeltà al governo di sua scelta.
Ma c'è un altro contratto che gioca un ruolo più importante. Esso può, forse, suona paradossale menzionare il contratto di fideiussione. fideiussione, al giorno d'oggi, è solo un obbligo accessorio, che presuppone un impegno principale, e che, per quanto riguarda la natura del contratto, è proprio come un altro. Ma, come è stato sottolineato da Laferriere, /1/ e molto probabilmente da scrittori precedenti, il garante della legge antica era l'ostaggio, e la consegna degli ostaggi non era affatto limitata alle trattative internazionali.
Nel vecchio romanzo metrico di Huon di Bordeaux, Huon, avendo ucciso il figlio di Carlo Magno, è richiesto dall'Imperatore per eseguire varie apparenti impossibilità come prezzo del perdono. Huon inizia il compito, lasciando dodici dei suoi cavalieri come ostaggi. /2/ Ritorna con successo, ma dapprima si fa credere all'imperatore che i suoi ordini siano stati disobbediti. Allora Carlo Magno grida:, “Invoco qui le promesse per Huon. li appenderò, e non avranno riscatto.” /3/ Così, quando Huon deve combattere un duello, mediante l'accertamento della verità o falsità di un'accusa contro di lui, ogni parte inizia producendo alcuni dei suoi amici come ostaggi.
Quando vengono dati ostaggi per un duello che deve determinare la verità o la falsità di un'accusa, l'operazione è molto vicina alla prestazione di analoga garanzia nel giudizio di una causa in tribunale. Questo era infatti il corso abituale della procedura germanica. Si ricorderà che la prima apparizione del diritto fu come sostituto delle faide private tra famiglie o clan. Ma mentre un imputato che non si sottometteva pacificamente alla giurisdizione del tribunale poteva essere messo al di fuori della protezione della legge, così che chiunque lo possa uccidere a vista, inizialmente non c'era modo di garantire l'indennità a cui aveva diritto l'attore a meno che il convenuto non avesse scelto di fornire tale garanzia. /1/
Le usanze inglesi che ci sono state conservate sono un po' più avanzate, ma una delle caratteristiche più evidenti nella loro procedura è la sicurezza ad ogni passo. Tutti gli avvocati ricorderanno una traccia di questo nella narrativa di John Doe e Richard Roe, l'impegno dell'attore a perseguire la sua azione. Ma un esempio più significativo si trova nella regola ripetuta in molte delle prime leggi, che un imputato accusato di un torto deve o trovare sicurezza o andare in prigione. /2/ Questa sicurezza era l'ostaggio dei giorni precedenti, e più tardi, quando le azioni di punizione e di riparazione erano separate l'una dall'altra, divenne la cauzione del diritto penale. La responsabilità era ancora concepita allo stesso modo di quando la cauzione metteva effettivamente il proprio corpo in potere della parte assicurata.
Una delle aggiunte di Carlo Magno alla Lex Salica parla di un uomo libero che si è affidato al potere di un altro a titolo di fideiussione. /3/ La stessa frase è copiata nelle leggi inglesi di Henry I. /4/ Abbiamo visto cosa questo significasse nella storia di Huon di Bordeaux. Lo specchio dei giudici /5/ dice che il re Canuto era solito giudicare i principali prigionieri secondo i principali quando i loro principali non in giudizio, ma quel re Enrico I. limitò la regola di Canuto ai principali prigionieri che erano consenzienti al fatto.
Fino al regno di Edoardo III., Coccio, un giudice inglese, dopo aver affermato la legge come è ancora, quella cauzione sono i custodi di un prigioniero, e sarà accusato se fugge, osserva, che alcuni dicono che la cauzione sarà impiccata al suo posto. /1/ Questa era la legge nel caso analogo di un carceriere. /2/ L'antica nozione va rintracciata nella forma ancora data dagli scrittori moderni per l'impresa della cauzione per reato. sono legati “corpo per corpo,” /3/ e i moderni libri di legge ritengono necessario affermare che ciò non li rende passibili della punizione del principale delinquente se non compare, ma solo per una multa. /4/ Il contratto differiva dalle nostre idee moderne anche nelle modalità di esecuzione. Era semplicemente una solenne ammissione di responsabilità alla presenza dell'ufficiale autorizzato a prenderla. La firma della cauzione non era necessaria, /5/ e non era necessario che la persona liberata si impegnasse come parte. /6/
Ma queste peculiarità sono state modificate o eliminate dallo statuto, e mi sono soffermato sul caso, non tanto come una forma speciale di contratto diversa da tutte le altre quanto perché la storia della sua origine mostra una delle prime apparizioni del contratto nel nostro diritto. È da ricondursi al graduale aumento della fede nell'onore di un ostaggio se dovesse arrivare il caso che chiedeva la sua resa, e al conseguente allentamento della carcerazione effettiva. Un esempio può essere trovato nel modo parallelo di trattare con il prigioniero stesso. la sua cauzione, a chi dovrebbe essere consegnato il suo corpo, hanno il diritto di catturarlo in qualsiasi momento e ovunque, ma gli è permesso di andare in libertà fino a quando non si arrese. Si noterà che questa forma di contratto, come il debito disciplinato dal diritto romano delle Dodici Tavole, e per lo stesso motivo, anche se con un processo diverso, guardava al corpo del contraente come la soddisfazione.
Il debito è un altro e più popolare candidato per gli onori di priorità. Dai tempi di Savigny, la prima apparizione del contratto sia nel diritto romano che in quello tedesco è stata spesso attribuita al caso di una vendita per qualche incidente rimasta incompleta. La domanda non sembra avere un grande significato filosofico. Per spiegare come l'umanità imparò per la prima volta a promettere, dobbiamo andare alla metafisica, e scopri come è mai arrivato a inquadrare un futuro. La natura della particolare promessa che è stata fatta rispettare per la prima volta in un dato sistema può difficilmente portare a una verità di importanza generale. Ma la storia dell'azione del debito è istruttiva, anche se in modo più umile. È necessario conoscerne qualcosa per comprendere le regole illuminate che costituiscono il diritto contrattuale attuale.
Già nel trattato di Glanvill si trova che l'azione del debito è uno dei rimedi più noti. Ma la legge di quei giorni era ancora in uno stato alquanto primitivo, e si può facilmente immaginare che una forma di azione che risale a non fosse fondata su discriminazioni molto delicate. Era, come cercherò di mostrare direttamente, semplicemente la forma generale in cui è stata riscossa qualsiasi richiesta di denaro, salvo richieste di risarcimento forzate non liquidate, per cui fu stabilito l'altrettanto generale rimedio della trasgressione.
Si è pensato che l'azione fosse stata adottata dall'allora più civile procedimento del diritto romano. Un parere naturale, visto che tutti i primi scrittori di diritto inglesi adottano la loro fraseologia e classificazione da Roma. Tuttavia sembra molto più probabile che l'azione sia di pura discendenza tedesca. Ha le caratteristiche della procedura primitiva che si trova nel Continente, come descritto da Laband. /1/
La sostanza della pretesa dell'attore, come esposta nell'atto di debito, è che l'imputato gli deve così tanto e lo trattiene ingiustamente. Non importa, per un reclamo strutturato in questo modo, come sorge il dovere del convenuto. Non si limita al contratto. È soddisfatto se c'è un dovere di pagamento per qualsiasi motivo. Afferma una mera conclusione di legge, non i fatti su cui si basa tale conclusione, e da cui deriva la responsabilità. La vecchia denuncia tedesca era, allo stesso modo, “A mi deve così tanto.”
Era caratteristico del procedimento tedesco che la convenuta potesse rispondere a tale censura rispondendo, in forma altrettanto generale, che non era debitore dell'attore. L'attore ha dovuto fare di più che semplicemente addurre un debito, se volesse impedire all'imputato di fuggire in quel modo. In Inghilterra, se l'attore non aveva qualcosa da mostrare per il suo debito, la smentita dell'imputato lo ha portato fuori dal tribunale; e anche se l'avesse fatto, rischiava di essere sconfitto dal giuramento dell'imputato con alcuni dei suoi amici di sostenerlo che non doveva nulla. Il motivo principale per cui il debito è stato soppiantato per secoli da un rimedio successivo, presunto, era la sopravvivenza di questa reliquia dei primi giorni.
Infine, in Inghilterra come in Germania, debito per detenzione di denaro era il fratello gemello dell'azione promossa per aver indebitamente trattenuto qualsiasi altro genere di beni mobili. L'essenza della denuncia in entrambi i casi era la stessa.
Sembra strano che questo rozzo prodotto dell'infanzia del diritto abbia una qualche importanza per noi in questo momento. Eppure ogni volta che risaliamo a una dottrina guida del diritto sostanziale abbastanza indietro, è molto probabile che alla fonte ci sia qualche circostanza di procedura dimenticata. Sono già state fornite illustrazioni di questa verità. L'atto di debito e le altre azioni di contratto ne forniranno altri. Il debito getta molta luce sulla dottrina della considerazione.
La nostra legge non fa rispettare ogni promessa che un uomo può fare. Promesse fatte come novantanove promesse su cento, con il passaparola o per semplice scrittura, non sono vincolanti a meno che non vi sia un corrispettivo per loro. Questo è, come viene comunemente spiegato, a meno che il promittente non abbia conferito un vantaggio al promittente, o subito un danno, come incentivo alla promessa.
Si è pensato che questa regola fosse stata presa in prestito dal diritto romano dalla Cancelleria, e, dopo aver subito alcune modifiche lì, passato al diritto comune.
Ma questo resoconto della questione è quantomeno discutibile. Per quanto riguarda l'uso delle parole, Non mi risulta che la considerazione sia distintamente chiamata causa prima del regno di Elisabetta; nei rapporti precedenti appare sempre come un quid pro quo. La sua prima apparizione, per quanto ne so, è nel resoconto di Fleta dell'azione del debito, /1/ e sebbene io sia incline a credere che non ci si debba fidare dell'affermazione di Fleta, mostrerà un'attenta considerazione dell'ordine cronologico dei casi negli Annuari, Penso, che la dottrina è stata completamente sviluppata nel debito prima che se ne possa trovare qualsiasi menzione nell'equità. Uno dei primi riferimenti a ciò che un promettente doveva avere per la sua impresa era nell'azione di assunzione. /1/ Ma la dottrina certamente non ha avuto origine lì. La prima menzione di considerazione in relazione all'equità che ho visto è sotto forma di quid pro quo, /2/ e si verifica dopo che il requisito era stato completamente stabilito nel debito. /3/
L'unico fatto che non è mai stato richiesto un corrispettivo per i contratti sotto sigillo, a meno che non ci si debba fidare di Fleta contro il grande peso di prove quasi contemporanee, va ben a dimostrare che la norma non può aver avuto origine per motivi di policy come norma di diritto sostanziale. E viceversa, la coincidenza della dottrina con un peculiare modo di procedere indica fortemente la probabilità che il peculiare requisito e il peculiare procedimento fossero collegati. Si farà luce sulla questione per mettere insieme alcuni fatti indiscussi, e considerare quali conseguenze naturalmente seguirono. Sarà quindi auspicabile esaminare un po' più a fondo l'azione del debito. Ma è giusto ammetterlo, all'inizio, che offro la spiegazione che segue con grande esitazione, e, Penso, con il pieno apprezzamento delle obiezioni che potrebbero essere avanzate.
È stato osservato un momento fa, Quello, al fine di recuperare contro un imputato che ha negato il suo debito, l'attore ha dovuto mostrare qualcosa per questo; altrimenti fu affidato alla giurisdizione limitata dei tribunali spirituali. /4/ Questa esigenza non significava prove in senso moderno. Significava semplicemente che doveva mantenere la sua causa in uno dei modi allora riconosciuti dalla legge. Questi erano tre, il duello, una scrittura, e testimoni. Il duello non deve essere discusso, poiché presto cessò di essere utilizzato in debito, e non ha attinenza con quello che ho da dire. Processo per iscritto e per testimoni, d'altro canto, devono essere entrambi studiati attentamente. Sarà opportuno considerare prima quest'ultimo e scoprire quali fossero questi testimoni.
Una cosa sappiamo all'inizio; non erano testimoni come intendiamo il termine. Non sono stati prodotti davanti a una giuria per l'esame e il controinterrogatorio, né la loro testimonianza dipendeva per il suo effetto dall'essere creduta dal tribunale che l'ha ascoltata. Al giorno d'oggi, un caso non è deciso dalle prove, ma con un verdetto, o una constatazione di fatti, seguito da un giudizio. Il giuramento di un testimone non ha effetto se non viene creduto. Ma al tempo di Enrico II. il nostro processo con giuria non esisteva. Quando un giuramento poteva essere prestato, aveva lo stesso effetto, che si credesse o meno. Non c'era alcuna disposizione per vagliarlo da un secondo corpo. Nei casi in cui era possibile un processo con testimoni, se il partito chiamato ad andare avanti potesse trovare un certo numero di uomini disposti a giurare in una certa forma, c'era una fine della questione.
Ora questo sembra un modo più primitivo per stabilire un debito rispetto alla produzione della conferma scritta dell'imputato, ed è materiale scoprirne l'origine.
I casi in cui è stata utilizzata questa modalità di prova sembrano dai primi libri e relazioni essere stati quasi del tutto confinati a crediti derivanti da una vendita o un prestito. E la domanda sorge subito, se non siamo sulle tracce di un'istituzione che era già antica quando scrisse Glanvill. Per secoli prima della conquista del diritto anglosassone /1/ aveva richiesto l'elezione di un certo numero di testimoni ufficiali, due o tre dei quali dovevano essere chiamati ad ogni affare di vendita. L'oggetto per il quale sono stati accertati questi testimoni non è comunemente ritenuto essere la prova dei debiti. Risalgono a un'epoca in cui il furto e reati simili erano il principale motivo di contenzioso, e lo scopo per il quale erano stati nominati era quello di permettersi un mezzo per decidere se una persona accusata di aver rubato qualcosa ne fosse venuto legittimamente o meno. Un imputato potrebbe scagionarsi dal reato con il giuramento di aver acquistato o ricevuto la cosa apertamente nel modo stabilito dalla legge.
Essendo stato presente all'affare, i testimoni hanno potuto giurare su ciò che avevano visto e sentito, in caso di domande tra le parti. Di conseguenza, il loro uso non si limitava a liquidare un'accusa di reato. Ma quel particolare servizio identifica i testimoni della transazione del periodo sassone. Ora sappiamo che l'uso di questi testimoni non scomparve subito sotto l'influenza normanna. Si trovano con la loro antica funzione nelle leggi di Guglielmo il Conquistatore. /1/ La lingua di Glanvill sembra dimostrare che erano ancora conosciuti sotto Enrico II. Lui dice che, se un acquirente non può convocare l'uomo da cui ha acquistato, garantirgli la proprietà e difendere la causa, (perché se lo fa, il pericolo è spostato sul venditore,) quindi se l'acquirente ha prove sufficienti di aver legittimamente comprato la cosa, del suo marchio legittimo, lo eliminerà dal crimine. Ma se non ha vestito sufficiente, sarà in pericolo. /2/ Questa è di nuovo la legge di William. Ne consegue che gli acquirenti hanno comunque utilizzato i testimoni della transazione.
Ma Glanvill sembra anche ammettere l'uso della testimonianza per stabilire i debiti. /1/ Poiché i testimoni della transazione erano precedentemente disponibili per questo scopo, Non vedo motivo di dubitare che lo fossero ancora, e che ne parla anche qui. /2/ Inoltre, per molto tempo dopo Enrico II., ogni volta che è stata intentata un'azione per un debito di cui non c'erano prove scritte, l'attore, quando gli è stato chiesto cosa doveva mostrare per questo, sempre risposto “buon vestito,” e offrì i suoi testimoni, che a volte venivano esaminati dal tribunale. /3/ Penso che non stia sforzando le prove per dedurre che il “buon vestito” dei rapporti successivi era il discendente dei testimoni della transazione sassone, come è stato dimostrato che era la secta di Glanvill. /4/
Supponendo che questo passaggio nell'argomento sia stato compiuto, sarà bene ricordare ancora per un momento l'originalità del giuramento testimoniale. Era limitato ai fatti all'interno dei testimoni’ conoscenza attraverso la vista e l'udito. Ma poiché gli scopi per i quali erano forniti i testimoni richiedevano la loro presenza solo quando la proprietà passava di mano, il caso principale in cui potrebbero essere al servizio tra le parti di un affare è stato quando è stato rivendicato un debito a causa della consegna della proprietà. Lo scopo non si estendeva agli accordi che erano esecutivi da entrambe le parti, perché non si potrebbe parlare di furto. E Glanvill mostra che ai suoi tempi la Corte del Re non faceva rispettare tali accordi. /1/ Adesso, se il giuramento della secta potesse essere utilizzato solo per stabilire un debito dove avrebbero giurato i testimoni della transazione, si vedrà, abbastanza prontamente, come un incidente di procedura possa aver portato a una norma di diritto sostanziale molto importante.
La regola che i testimoni possono giurare solo sui fatti a loro conoscenza, insieme all'incidente che questi testimoni non sono stati utilizzati in transazioni che potrebbero creare un debito, salvo un fatto particolare, vale a dire, la consegna della proprietà, insieme all'ulteriore incidente che questa consegna era quid pro quo, era equivalente alla regola che, quando un debito è stato provato da testimoni ci deve essere un quid pro quo. Ma questi debiti provati da testimoni, invece che per atto sono quelli che chiamiamo semplici debiti contrattuali, e quindi a cominciare dal debito, e successivamente estendendosi ad altri contratti, è stabilita la nostra dottrina peculiare e più importante che ogni semplice contratto deve avere una considerazione. Questa non è mai stata la legge sui debiti o sui contratti provata nel solito modo dal sigillo dell'imputato, e il fatto che si applicava solo agli obblighi che erano stati precedentemente stabiliti da una procedura di uso limitato, va lontano per dimostrare che il collegamento con la procedura non è stato casuale.
La modalità di prova cambiò presto, ma fino al regno della regina Elisabetta troviamo una traccia di questo legame originario. Si dice, “Ma la legge comune richiede che ci sia una nuova causa (io. e. considerazione), di cui il paese può avere intelligenza o conoscenza per il suo processo, se necessario, così che è necessario per il bene pubblico.” /1/ Lord Mansfield ha mostrato la sua intuizione dei motivi storici della nostra legge quando ha detto, “Presumo che l'antica nozione di mancanza di considerazione fosse solo a scopo di prova; per quando è ridotto in scrittura, come nei patti, specialità, obbligazioni, eccetera., non c'era obiezione alla mancanza di considerazione.” /2/
Se si deve obiettare che l'argomento precedente è necessariamente limitato al debito, mentre il requisito del corrispettivo si applica ugualmente a tutti i contratti semplici, la risposta è, che con ogni probabilità la regola ha avuto origine dal debito, e diffusione dal debito ad altri contratti.
Ma, ancora, ci si può chiedere se non vi fossero altri contratti provati da testimoni se non quelli citati. Non ci fossero contratti provati in quel modo a cui mancasse la considerazione accidentale? Anche a questo c'è una risposta facile. I contratti eseguiti dai tribunali civili, anche fino a Enrico II., erano pochi e semplici. La procedura dei testimoni era senza dubbio sufficientemente ampia per tutti i contratti stipulati nei primi tempi. Oltre a quelli di vendita, prestito, e simili, che sono stati citati, Non trovo che due obblighi contrattuali. Queste erano le garanzie che accompagnavano una vendita e fideiussione cui si faceva riferimento all'inizio della Lezione. Del primo, la garanzia di proprietà era considerata piuttosto come un obbligo sollevato dalla legge dal rapporto tra acquirente e venditore che come un contratto. Altre garanzie espresse erano questioni a conoscenza dei testimoni della transazione, e furono giurati da loro in epoca sassone. /1/
Ma nel periodo normanno si sente molto poco la garanzia, tranne che per quanto riguarda la terra, e poi fu deciso dal duello. È così del tutto scomparso, tranne dove è stato incarnato in un atto, che non può aver avuto alcuna influenza sulla legge del corrispettivo. Presumo quindi, senza ulteriori dettagli, che non riguarda il caso./1/
Poi per quanto riguarda il pegno o fideiussione. Non ha più pagato con il suo corpo, salvo casi del tutto eccezionali, ma la sua responsabilità è stata tradotta in denaro, ed eseguito in un atto di debito. Questo contratto secolare, come gli altri debiti del tempo di Glanvill, potrebbe essere stabilito da un testimone senza una scrittura, /2/ e in questo caso non c'era tale considerazione, un tale vantaggio per il promittente, come la legge richiesta quando la dottrina fu enunciata per la prima volta. Ma anche questo non è importante, perché la sua responsabilità sul giuramento di testimone è venuta meno, così come quella del garante, prima che fossero poste le basi per la regola che sto cercando di spiegare. Presto si rese necessaria una scrittura, come si vedrà tra poco.
Il risultato finora è, che l'unico atto contrattuale ai tempi di Glanvill era il debito, che gli unici debiti recuperati senza scrivere erano quelli che sono stati descritti, e che l'unico di questi per cui non c'era quid pro quo cessò di essere recuperabile in quel modo durante il regno di Edoardo III.
Ma grandi cambiamenti stavano iniziando durante il regno di Enrico II. Ben presto vennero applicati contratti più vari e complessi. Potrebbe essere chiesto, Perché la portata del giuramento del testimone non è stata ampliata, o, se una prova migliore fosse imminente, perché la setta non è stata eliminata, e altre testimonianze orali ammesse? In ogni caso, cosa può avere a che fare la legge del tempo di Enrico II con la considerazione, di cui non si è sentito parlare fino a secoli dopo?
È evidente che un giuramento di testimone, che risolve un caso per il semplice fatto che è giurato, non è una modalità di prova soddisfacente. Un'ammissione scritta di debito prodotta in tribunale, e sufficientemente identificato come emittente dal convenuto, ovviamente è molto meglio. L'unico punto debole di uno scritto è il mezzo per identificarlo come quello dell'imputato, e questa difficoltà scomparve non appena divenne comune l'uso dei sigilli. Ciò era avvenuto più o meno ai tempi di Glanvill, e quindi tutto ciò che una parte doveva fare era produrre la scritta e soddisfare il tribunale verificando che l'impronta sulla cera corrispondeva al sigillo del suo avversario. /1/ Il giuramento della secta poteva sempre essere soddisfatto con successo con la scommessa della legge, /2/ questo è, con controgiuramento da parte dell'imputato, con lo stesso o il doppio del numero di confratelli prodotti dall'attore. Ma una scrittura risultata essere dell'imputato non poteva essere contraddetta. /1/ Perché se un uomo ha detto che era legato, era legato. Non c'era questione di considerazione, perché non esisteva ancora una tale dottrina. Era ugualmente vincolato se riconosceva tutti gli obblighi in qualsiasi luogo avendo un record, come le corti superiori, da cui potrebbe essere provato il suo riconoscimento. Infatti, ancora oggi alcuni titoli sono presi semplicemente per ammissione orale davanti al cancelliere di un tribunale da lui annotato nelle sue carte. Il vantaggio della scrittura non era solo quello di fornire una prova migliore nei vecchi casi, ma anche che consentiva di far rispettare obblighi per i quali altrimenti non ci sarebbe stata alcuna prova.
Quanto è stato detto spiega sufficientemente la preferenza della prova scrivendo alla prova con il vecchio giuramento di testimonianza. Ma c'erano altre ragioni altrettanto valide per cui quest'ultimo non doveva essere esteso oltre i suoi antichi limiti. I testimoni della transazione stavano perdendo il loro carattere legale e ufficiale. Già ai tempi di Glanvill le modalità usuali per provare un debito erano il duello o la scrittura. /2/ Cento anni dopo Bracton mostra che la secta era degenerata in servitori e famiglie del partito, e dice che il loro giuramento suscita solo una leggera presunzione. /3/
Inoltre, stava nascendo una nuova modalità di prova, quale, sebbene non sia stato utilizzato in questi casi /4/ per un bel po', doveva tendere, per contrasto, a diminuire la stima fissata sul giuramento di testimone. Questo fu l'inizio del nostro processo con giuria. All'inizio era un'inchiesta sui vicini che molto probabilmente erano a conoscenza di una questione di fatto controversa. Hanno parlato per loro conoscenza, ma furono scelti da un ufficiale del tribunale invece che dalla parte interessata, e dovevano essere imparziali. /1/ Ben presto i testimoni furono convocati davanti a loro, non, come in passato, al caso con il loro giuramento, ma per aiutare l'inchiesta a trovare un verdetto dalla loro testimonianza. Con l'avvento di questa procedura illuminata, la secta cessò presto di decidere sul caso, e ci si può chiedere perché non sia scomparso e non abbia lasciato tracce.
Tenendo conto del conservatorismo della legge inglese, e il fatto che, prima che arrivassero i fatti, gli unici debiti per i quali c'era stato rimedio erano i debiti provati dai testimoni dell'operazione, non sarebbe stata una sorpresa vedere che l'offerta di causa persisteva in quei casi. Ma c'era un altro motivo ancora più imperativo. La difesa in debito dove non c'era atto era per scommessa di legge. /2/ Una sezione della Magna Charta è stata interpretata in modo da vietare che un uomo sia sottoposto alla sua legge sulla dichiarazione dell'attore senza una buona testimonianza. /3/ Quindi, lo statuto richiedeva un testimone, cioè, la secta: in ogni caso di debito in cui l'attore non ha fatto affidamento su uno scritto. Così accadde che la causa continuasse ad essere offerta in quei casi in cui era stata antica, /4/ e come imputato, se non ha ammesso il debito in tali casi, ha sempre intrapreso la sua legge, passò molto tempo prima che l'inchiesta prendesse molto piede.
Stabilire un debito sorto semplicemente a titolo di promessa o riconoscimento, e per la quale in precedenza non era stata prevista alcuna modalità di prova, devi avere una scritta, la nuova forma di prova che l'ha introdotta nella legge. La regola è stata dettata, “per autorizzazione la parte non è obbligata.” /1/ Ma i vecchi debiti non erano concepiti come sollevati da una promessa. /2/ Erano un “dovere” scaturito dal ricevimento della proprietà da parte dell'attore, un fatto che potrebbe essere visto e giurato. In questi casi la vecchia legge si manteneva e si estendeva anche un po' per stretta analogia.
Ma l'assunzione di una fideiussione, in qualunque forma fosse vestito, in realtà non è derivato da alcun fatto del genere. Era diventato della stessa natura delle altre promesse, e fu presto messo in dubbio se non dovesse essere provato con la stessa prova. /3/ Con il regno di Edoardo III., è stato stabilito che era necessario un atto, /4/ salvo che i costumi di determinate città avessero mantenuto in vigore l'antica legge. /5/
Questo regno può essere preso come rappresentante del tempo in cui furono stabilite le divisioni e le regole di procedura che sono durate fino ai giorni nostri. Vale quindi la pena di ripetere e riassumere la condizione della legge in quel momento.
Era ancora necessario che la secta fosse appaltata in ogni atto di debito per il quale non fosse prodotto scritto. Per questo, così come per gli altri motivi che sono stati citati, la sfera di tali azioni non si è materialmente allargata al di là di quelle cause che erano state precedentemente stabilite dal giuramento di testimoni. Poiché la fideiussione non era più una di queste, sono diventati strettamente limitati ai casi in cui il debito è sorto dalla ricezione di un quid pro quo. Inoltre non c'era nessun altro atto contrattuale che potesse essere mantenuto senza una scrittura. Nuove specie di contratti erano ora applicate da un'azione di patto, ma lì era sempre necessario un atto. Allo stesso tempo la secta si era ridotta a una forma, sebbene si sostenesse ancora che la sua funzione fosse più importante nel contratto che altrove. Non poteva più essere esaminato davanti al tribunale. /1/ Era una semplice sopravvivenza, e il testimone della transazione aveva cessato di essere un'istituzione. Quindi, la necessità di prestare giuramento testimoniale non fissava il limite del debito sul semplice contratto se non per tradizione, e non sorprende scoprire che l'azione è stata leggermente estesa per analogia dalla sua portata al tempo di Glanvill.
Ma il debito è rimasto sostanzialmente al punto che ho indicato, e per un secolo non è stata introdotta nessuna nuova azione disponibile per i contratti semplici. Nel frattempo avveniva l'inversione che ho spiegato, e quello che era un accidente di procedura era diventato una dottrina del diritto sostanziale. Il cambiamento fu facile quando i debiti che potevano essere fatti valere senza atto scaturirono tutti da un vantaggio per il debitore.
L'influenza del diritto romano, senza dubbio, aiutato a raggiungere questo risultato. Si ricorderà che durante il regno di Enrico II. i contratti più semplici e i debiti per i quali non esisteva la prova dell'atto o della testimonianza venivano lasciati all'esecuzione dai tribunali ecclesiastici, nella misura in cui la loro giurisdizione si estendeva. /2/ Forse è stata questa circostanza che ha portato Glanvill e i suoi successori ad applicare la terminologia dei civili ai debiti di diritto comune. Ma se l'ha preso in prestito dai tribunali ecclesiastici, o andò direttamente alla fonte, certo è che Glanvill fa uso della classificazione e del linguaggio tecnico del Corpus Juris in tutto il suo decimo libro.
C'erano alcuni contratti speciali nel sistema romano chiamati reali, il che obbligava l'appaltatore o a restituire una certa cosa messa nelle sue mani dall'appaltatore, come in caso di locazione o prestito, o per consegnare altri articoli della stessa natura, come quando il grano, olio, o il denaro è stato prestato. Questa classe non corrispondeva, tranne che nel modo più superficiale, con i debiti di diritto comune. Ma Glanvill adottò la nomenclatura, e gli scrittori successivi iniziarono a trarne conclusioni. L'autore di Fleta, uno scrittore non sempre intelligente nel seguire e adottare i suoi predecessori’ uso del diritto romano, /1/ dice che per alzare un debito non ci deve essere solo una certa cosa promessa, ma una certa cosa promessa in cambio. /2/
Se Fleta avesse limitato la sua dichiarazione ai debiti per semplice contratto, potrebbe benissimo essere stato suggerito dallo stato attuale della legge. Ma poiché richiedeva anche una scritta e un sigillo, oltre alla cosa data o promessa in cambio, la dottrina da lui dettata difficilmente può aver prevalso in nessun momento. Probabilmente non era altro che un leggero capriccio di ragionamento basato sugli elementi romani che aveva preso in prestito da Bracton.
Resta solo da tracciare la graduale apparizione della considerazione nelle decisioni. Un caso del regno di Edoardo III. /1/ sembra distinguere tra un'obbligazione fondata su pagamenti volontari da parte del creditore e una fondata su un pagamento su richiesta del debitore. Si parla anche del debito o “dovere” in tal caso come derivanti da causa di pagamenti. Un linguaggio in qualche modo simile viene utilizzato nel prossimo regno. /2/ Così, nel dodicesimo anno di Enrico IV., /3/ c'è un approccio al pensiero: “Se i soldi sono promessi a un uomo per fare una liberazione, e fa il rilascio, avrà una buona azione di debito in materia.” Nel prossimo regno /4/ è stato deciso così, in tal caso, l'attore non poteva riprendersi senza aver eseguito il rilascio, che viene spiegato dal direttore con la motivazione che ex nudo pacto non oritur actio. Ma il fatto più importante è, quello di Edoardo I. due Enrico VI. non troviamo alcun caso in cui sia stato recuperato un debito, a meno che non sia stato effettivamente ricevuto un corrispettivo.
Un altro fatto da notare è, che da Edoardo III. si dice che i debiti derivanti da una transazione senza scrittura derivino dal contratto, distinto dai debiti derivanti da un'obbligazione. /5/ Quindi, quando la considerazione era richiesta in quanto tale, era richiesto nei contratti non sotto sigillo, se debiti o meno. Sotto Enrico VI. il quid pro quo è diventato una necessità in tutti questi contratti. Nel terzo anno di quel regno /6/ è stato contestato l'au action su un presupposto per non aver costruito un mulino, che non è stato mostrato cosa doveva avere l'imputato per farlo. Nel trentaseiesimo anno dello stesso regno (anno Domini. 1459), la dottrina appare pienamente cresciuta, e si presume sia familiare. /1/
Il caso ha sollevato una questione che è stata dibattuta per secoli prima di essere risolta, se il debito mentirebbe per una somma di denaro promessa dall'imputato all'attore se avesse sposato la figlia dell'imputato. Ma mentre in precedenza si era discusso se la promessa non fosse così legata al matrimonio da appartenere esclusivamente alla giurisdizione dei tribunali spirituali, ora toccava il dubbio puramente mondano se l'imputato avesse avuto un quid pro quo.
Si ricorderà che il fatto già asseverato dai testimoni dell'operazione costituiva un vantaggio per l'imputato, vale a dire, una consegna delle cose vendute o del denaro prestatogli. Tali casi, anche, offrire la forma più ovvia di considerazione. La domanda naturale è, cosa doveva avere il promettente per la sua promessa. /2/ È solo dall'analisi che la presunta politica della legge si vede ugualmente soddisfatta da un danno subito dal promesso. Non è quindi accaduto in modo innaturale che i giudici, quando stabilirono per la prima volta la legge che doveva esserci il quid pro quo, hanno tardato a riconoscere un danno per il contraente come conforme al requisito che era stato stabilito. Nel caso che ho citato alcuni giudici erano propensi a ritenere che liberarsi della figlia fosse un vantaggio sufficiente per l'imputato per fargli debitore per il denaro che aveva promesso; e c'era anche qualche accenno di opinione, che sposare la signora era una considerazione, perché era un danno per il promesso. /1/ Ma prevalse l'altra opinione, almeno per un po', perché il convenuto non aveva avuto nulla da parte dell'attore per aumentare un debito. /2/
Quindi si è ritenuto che un servizio reso a un terzo su richiesta dell'imputato e promessa di compenso non sarebbe stato sufficiente, /3/ anche se non senza forti opinioni contrarie, e per un certo tempo i precedenti furono risolti. Si è stabilito che un atto di debito sarebbe dovuto solo a un corrispettivo effettivamente ricevuto e a beneficio del debitore.
Era, però, nessuna particolarità né dell'azione né del contratto di debito che ha portato a questo punto di vista, ma la teoria della considerazione imperfettamente sviluppata prevalente tra i regni di Enrico VI. ed Elisabetta. La teoria lo stesso in presupposto, /4/ e in equità. /5/ Ovunque sia stata menzionata la considerazione, era sempre come un quid pro quo, come quello che l'appaltatore doveva avere per il suo contratto.
Inoltre, prima che se ne sentisse parlare, il debito era l'antico rimedio contro ogni obbligo di pagamento imposto dalla legge, salva la responsabilità per danni per torto. /6/ È stato già dimostrato che un fideiussore poteva essere citato in giudizio fino al tempo di Edoardo III. senza una scritta, tuttavia un garante non riceve alcun vantaggio dal rapporto con il suo principale. Per esempio, se un uomo vende il mais ad A, e B dice, “Pagherò se A non lo fa,” la vendita B non va bene per quanto appare dai termini dell'affare. Per questa ragione, il debito non può ora essere mantenuto contro una fideiussione in un caso del genere.
Non è sempre stato così. Non è così fino ad oggi se c'è un obbligo sotto sigillo. In quel caso, non importa come sia sorto l'obbligo, o se ci fosse qualche considerazione per questo o meno. Ma uno scritto era un modo più generale per stabilire un debito ai tempi di Glanvill rispetto a un testimone, ed è assurdo determinare la portata dell'azione prendendo in considerazione una sola classe di debiti dalla stessa fatti valere. Inoltre, una scrittura per molto tempo è stata solo un'altra, anche se più conclusivo, modalità di prova. Il fondamento dell'azione era lo stesso, tuttavia è stato dimostrato. Questo era un dovere o “dovere” /1/ all'attore, in altre parole, quel denaro gli era dovuto, non importa come, come chiunque può vedere leggendo i libri dell'anno precedente. Quindi è stato, quel debito poggiava ugualmente su un giudizio, /2/ che ha stabilito un tale dovere per materia, o su ammissione del convenuto registrato in modo simile. /3/
Per riassumere, l'azione del debito ha attraversato tre fasi. All'inizio, era l'unico rimedio per recuperare il denaro dovuto, tranne quando la responsabilità era semplicemente quella di risarcire un atto illecito. Era molto simile - anzi non era che una branca - dell'azione per qualsiasi forma di proprietà personale che il convenuto era obbligato contrattualmente o altrimenti a consegnare all'attore. /4/ Se ci fosse un contratto per pagare i soldi, l'unica domanda era come si poteva dimostrarlo. Qualsiasi contratto del genere, che potrebbe essere provato con uno qualsiasi dei mezzi noti al diritto antico, costituiva un debito. Non esisteva una teoria della considerazione, e quindi, Certo, nessun limite né all'azione né al contratto in base alla natura del corrispettivo ricevuto.
La seconda fase è stata quando la dottrina della considerazione è stata introdotta nella sua forma precedente di vantaggio per il promittente. Ciò si applicava a tutti i contratti non sotto sigillo mentre prevaleva, ma è stato stabilito mentre il debito era l'unica azione per denaro pagabile da tali contratti. I precedenti sono, per la maggior parte, precedenti in debito.
La terza fase è stata raggiunta quando è stata presa in considerazione una visione più ampia, ed è stato espresso in termini di danno al promesso. Questo cambiamento è stato un cambiamento nel diritto sostanziale, e logicamente avrebbe dovuto essere applicato dappertutto. Ma sorse in un'altra e successiva forma di azione, in circostanze particolarmente connesse a tale azione, come verrà spiegato in seguito. Il risultato fu che la nuova dottrina prevalse nella nuova azione, e il vecchio nel vecchio, e che quella che era realmente l'anomalia di teorie inconsistenti affiancate si travestiva sotto forma di limitazione all'azione del debito. Quell'azione non è rimasta, come prima, il rimedio per tutti i contratti vincolanti per il pagamento di denaro, ma, per quanto riguarda i contratti di autorizzazione, poteva essere utilizzato solo se il corrispettivo era un vantaggio effettivamente percepito dal promittente. Per quanto riguarda gli obblighi derivanti in altro modo, è rimasto invariato.
Devo ora dedicare alcune parole all'effetto sulla nostra legge dell'altro modo di prova che ho menzionato. Intendo charter. Una carta era semplicemente una scrittura. Come pochi potrebbero scrivere, la maggior parte delle persone doveva autenticare un documento in qualche altro modo, per esempio, lasciando il segno. Questo era, infatti, la pratica universale in Inghilterra fino all'introduzione delle usanze normanne. /1/ Con loro sono entrati i sigilli. Ma fino a Enrico II. il Presidente della Corte Suprema d'Inghilterra disse che appartenevano propriamente solo ai re e a uomini molto grandi. /2/ Non ho motivo di pensare che una carta autentica avesse un effetto minore in quel momento quando non era sigillata rispetto a quando era sigillata. /3/ Era solo una prova in entrambi i casi, ed è chiamato così in molti dei primi casi. /4/ Si potrebbe rinunciare, e vestito offerto al suo posto. /5/ Il suo effetto conclusivo era dovuto alla natura soddisfacente delle prove, non al sigillo. /6/
Ma quando i sigilli sono entrati in uso, ovviamente, hanno migliorato le prove della carta, in quanto il sigillo era più difficile da contraffare che un tratto di penna. I sigilli acquisirono tale importanza, Quello, per un periodo, un uomo era legato dal suo sigillo, anche se è stato apposto senza il suo consenso. /7/ Alla fine venne richiesto un sigillo, affinché una carta abbia il suo antico effetto. /8/
Un patto o un contratto sotto sigillo non era più una promessa ben dimostrata; era una promessa di natura distinta, per la quale è stata prevista una forma distinta di azione. /1/ Ho mostrato come il requisito della considerazione sia diventato una norma di diritto sostanziale, e anche perché non ha mai avuto alcun punto d'appoggio nel dominio delle alleanze. L'eccezione dei covenants dal requisito è diventata anche una norma di diritto sostanziale. L'uomo che aveva messo mano a una carta, dall'essere legato perché aveva acconsentito a esserlo, e perché c'era una scritta a dimostrarlo, /2/ era ora tenuto per forza del sigillo e per atto solo come distinto da tutti gli altri scritti. E per mantenere l'integrità di una teoria inadeguata, si diceva un sigillo a una considerazione.
Al giorno d'oggi, a volte si ritiene più filosofico dire che un patto è un contratto formale, che sopravvive accanto al contratto consensuale ordinario, proprio come avveniva nel diritto romano. Ma nemmeno questo è un modo molto istruttivo di dirlo. In un senso, tutto è forma che la legge richiede per rendere una promessa vincolante al di là della mera espressione della volontà del promittente. La considerazione è una forma tanto quanto un sigillo. L'unica differenza è, quella forma è di introduzione moderna, e ha una base in buon senso, o almeno nelle nostre abitudini di pensiero comuni, in modo che non ce ne accorgiamo, mentre l'altro è una sopravvivenza da una condizione più antica della legge, ed è meno manifestamente ragionevole, o meno familiare. posso aggiungere, Quello, sotto l'influenza di quest'ultima considerazione, la legge delle alleanze sta venendo meno. In molti Stati si ritiene che una semplice pergamena o un disegno della penna sia un sigillo sufficiente. Da ciò il passo è breve abolire del tutto la distinzione tra strumenti sigillati e non sigillati, e questo è stato fatto in alcuni degli Stati occidentali.
Mentre le alleanze sopravvivono in una vecchiaia alquanto debole, e il debito è scomparso, lasciando dietro di sé un'influenza vagamente inquietante, tutto il diritto contrattuale moderno è cresciuto per mezzo dell'azione di Assunta, che ora deve essere spiegato.
Dopo la conquista normanna tutte le azioni ordinarie furono avviate con atto del re, e ordinando al convenuto di essere citato in giudizio per rispondere all'attore. Questi atti sono stati emessi come una cosa ovvia, nei vari atti noti da cui hanno preso il nome. C'erano atti di debito e di patto; c'erano atti di violazione di domicilio per lesioni forzate alla persona dell'attore, o ai beni in suo possesso, e così via. Ma questi atti sono stati emessi solo per le azioni che erano note alla legge, e senza un atto la corte non aveva l'autorità per giudicare un caso. Al tempo di Edoardo I. c'erano solo poche di tali azioni. I casi in cui si potevano recuperare soldi di un altro rientravano in un ristretto numero di gruppi, per ciascuno dei quali esisteva una forma particolare di citazione e di pretesa.
Queste forme avevano cessato di essere adeguate. Così sono stati molti i casi che non rientravano esattamente nella definizione di violazione di domicilio, ma per il quale era opportuno che fosse fornito un rimedio. Per fornire un rimedio, la prima cosa da fare era fornire un mandato. Di conseguenza, il famoso statuto di 13 Edoardo I., c. 24, autorizzava l'ufficio da cui emettevano i vecchi atti a inquadrarne di nuovi in casi simili in linea di principio a quelli per i quali erano stati trovati atti, e richiede un simile rimedio, ma non esattamente rientrante nell'ambito delle scritture già in uso.
Così iniziarono a fare la loro comparsa gli atti di trasgressione sul caso; questo è, atti indicando un motivo di denuncia per violazione di domicilio, ma non del tutto pari a una violazione di domicilio come era stato citato in giudizio nei precedenti precedenti. Per fare un'istanza che è sostanzialmente uno dei primi casi, supponiamo che un uomo abbia lasciato un cavallo da un fabbro per essere ferrato, e con negligenza conficcò un chiodo nel piede del cavallo. Potrebbe essere che il proprietario del cavallo non potesse avere uno dei vecchi mandati, perché il cavallo non era in suo possesso quando il danno è stato fatto. Una stretta violazione di proprietà poteva essere commessa solo nei confronti della persona in possesso di essa. Non poteva essere commesso da chi ne fosse in possesso lui stesso. /1/ Ma come zoppicare il cavallo era ugualmente un torto, se il proprietario teneva il cavallo per le briglie o lo lasciava al fabbro, e poiché il torto era strettamente analogo a una trasgressione, sebbene non uno, la legge ha dato al proprietario un atto di violazione di domicilio sul caso. /2/
Un esempio come questo non pone alcuna difficoltà; è tanto un atto illecito per un torto quanto la violazione stessa. Nessun contratto è stato dichiarato, e nessuno era necessario per principio. Ma questo non appartiene alla classe dei casi da considerare, perché il problema davanti a noi è di risalire all'origine dell'assunzione, che è un atto di contratto. Ha assunto, però, iniziato come un atto di violazione del caso, e la cosa da scoprire è come la violazione del caso sia mai diventata disponibile per una semplice violazione dell'accordo.
Sarà bene esaminare alcuni dei primi casi in cui un'impresa (presunto) è stato affermato. Il primo riportato nei libri è del regno di Edoardo III. /3/ L'attore ha affermato che il convenuto si è impegnato a trasportare il cavallo dell'attore in sicurezza attraverso l'Humber, ma sovraccaricato la barca, a causa della quale il cavallo perì. È stato obiettato che l'azione avrebbe dovuto essere un patto per violazione dell'accordo, oppure trasgredire. Ma è stato risposto che l'imputato ha commesso un atto illecito quando ha caricato la barca, e l'obiezione è stata respinta. Di nuovo questo caso, anche se è stato dichiarato un impegno, appena introdotto un nuovo principio. La forza non procedeva direttamente dall'imputato, per essere sicuro, ma è stato messo in atto dalla combinazione del suo sovraccarico e poi della spinta nel ruscello.
Il caso successivo è dello stesso regno, e va oltre. /1/ L'atto prevedeva che l'imputato si impegnasse a curare la malattia del cavallo dell'attore (il cavallo del suddetto W. di infermiere), e fece il suo lavoro così negligentemente che il cavallo morì. Ciò differisce dal caso di zoppicare il cavallo con un chiodo per due aspetti. Non addebita alcun atto forzato, né in effetti alcun atto a tutti, ma una semplice omissione. D'altro canto, si afferma un impegno, cosa che l'altro no. La convenuta ha subito obiettato che si trattava di un'azione per violazione di un impegno, e che l'attore avrebbe dovuto portare un patto. L'attore ha risposto, che non poteva farlo senza un atto, e che l'azione era per negligenza provocata la morte del cavallo; questo è, per un illecito, non per inadempimento contrattuale. Quindi, disse l'imputato, potresti aver avuto una violazione. Ma l'attore ha risposto dicendo che il cavallo non è stato ucciso con la forza, ma morì per def. curare; e su questo argomento l'atto fu giudicato buono, Thorpe, J. dicendo di aver visto un uomo accusato di aver ucciso un paziente per mancanza di cure (default nella stagionatura), che si era impegnato a curare.
Entrambi questi casi, si vedrà, sono state trattate dal tribunale come pure atti illeciti, nonostante l'affermazione di impegno da parte della convenuta. Ma si vedrà anche che sono via via più lontane da un caso ordinario di violazione di domicilio. Nell'ultimo caso dichiarato, specialmente, la forza distruttrice non procedeva in alcun modo dall'imputato. E così ci troviamo di fronte alla domanda, Quale possibile analogia si sarebbe potuta trovare tra un atto illecito che produce un danno, e una mancanza di azione a tutti?
Provo a rispondere, permettetemi di illustrare un po' ulteriormente con esempi di data un po' più tarda. Supponiamo che un uomo si impegni a lavorare nella casa di un altro, e con la sua inabilità ha rovinato il legname del suo datore di lavoro; sarebbe come una violazione di domicilio, sebbene non uno, e il datore di lavoro farebbe causa per violazione di domicilio sul caso. Questo è stato affermato come legge chiara da uno dei giudici durante il regno di Enrico IV. /1/ Ma supponiamo che, invece di rovinare direttamente i materiali, il falegname aveva semplicemente lasciato un buco nel tetto attraverso il quale era entrata la pioggia e aveva fatto il danno. Si segnala l'analogia con il caso precedente, ma siamo un passo più lontano dalla trasgressione, perché la forza non viene dall'imputato. Eppure in questo caso anche i giudici pensavano che la violazione del caso sarebbe stata una bugia. /2/ Al tempo di Enrico IV. l'azione non poteva essere mantenuta per un semplice rifiuto di costruire secondo accordo; ma è stato suggerito dalla corte, Quello, se l'atto lo avesse menzionato “che la cosa era stata iniziata e poi non fatta, sarebbe stato altrimenti.” /3/
Ritorno ora alla domanda, Quale somiglianza poteva esserci tra un'omissione e una violazione di domicilio sufficiente a giustificare un atto di violazione del caso? Per trovare una risposta è indispensabile rilevare che in tutti i casi precedenti l'omissione si è verificata nel corso dei rapporti con la persona o il patrimonio dell'attore, e arrecato danno all'uno o all'altro. Alla luce di questo fatto, Il riferimento di Thorpe alle accuse per aver ucciso un paziente per mancanza di cure, e la successiva distinzione tra negligenza prima e dopo l'inizio del compito, sono più incinte. Il primo diventa ancora più suggestivo quando si ricorda che questo è il primo argomento o analogia da trovare sull'argomento.
Il significato di tale analogia è chiaro. Anche se un uomo ha il diritto perfetto di stare a guardare e vedere la proprietà del suo vicino distrutta, o, per questo, vedere il suo prossimo morire per mancanza del suo aiuto, ma se una volta si immischia non ha più la stessa libertà. Non può ritirarsi a suo piacimento. Per fare un esempio più specifico, se un chirurgo per benevolenza taglia il cordone ombelicale di un neonato, non può fermarsi lì e guardare il paziente morire dissanguato. Sarebbe un omicidio intenzionalmente permettere che la morte avvenga in quel modo, come se l'intenzione fosse stata intrattenuta al momento di tagliare la corda. Non importa se la malvagità è iniziata con l'atto, o con la successiva omissione.
Lo stesso ragionamento vale per la responsabilità civile. Un falegname non ha affatto bisogno di andare a lavorare nella casa di un altro uomo, ma se accetta la fiducia dell'altro e si immischia, non può fermarsi a suo piacimento e lasciare il tetto aperto alle intemperie. Quindi nel caso del maniscalco, quando aveva preso in carico il cavallo, non poteva fermarsi al momento critico e lasciare le conseguenze alla fortuna. Così, ancora più chiaramente, quando il traghettatore si impegnò a portare un cavallo attraverso l'Humber, anche se l'acqua ha annegato il cavallo, i suoi atti remoti di sovraccaricare la sua barca e spingerla nella corrente in quelle condizioni hanno causato la perdita, e lui ne era responsabile.
Nei casi precedenti il dovere era indipendente dal contratto, o almeno era così considerato dai giudici che li hanno decisi, e si atteneva alle regole generali applicate alla condotta umana anche dal diritto penale. L'occasione immediata del danno lamentato potrebbe essere stata una mera omissione di entrare nell'azione di forze naturali. Ma se lo colleghi, come era collegato di fatto, con i precedenti rapporti, hai una linea di condotta e condotta che, preso nel suo insieme, ha causato o cagionato il danno.
L'obiezione può essere sollecitata, per essere sicuro, che c'è un passo considerevole dal ritenere un uomo responsabile delle conseguenze dei suoi atti che avrebbe potuto impedire, a renderlo responsabile di non aver interferito con il corso della natura quando non l'ha messa in moto né aperto la porta perché le facesse del male, e che c'è proprio quella differenza tra fare un buco in un tetto e lasciarlo aperto, o tagliando il cavo e lasciandolo sanguinare, da un lato, e il caso di un maniscalco che riceve un cavallo malato e omette le dovute precauzioni, dall'altra. /1/
Sembra che ci siano due risposte a questo. Primo, non è chiaro se una tale distinzione sia stata proposta dal tribunale che ha deciso la causa che ho menzionato. È stato affermato che l'imputato ha eseguito la sua cura in modo così negligente che il cavallo è morto. Ai giudici non sarebbe forse venuto in mente che la condotta dell'imputato non fosse forse andata oltre l'omissione di una serie di misure vantaggiose. Probabilmente si presumeva consistesse in una combinazione di atti e negligenze, il che, nel suo insieme, equivaleva a un trattamento improprio della cosa.
Nel posto successivo, è dubbio che la distinzione sia valida per motivi pratici. Potrebbe benissimo essere quello, fintanto che si permette che in lui sia riposta una fiducia, è tenuto a usare le precauzioni a lui note, anche se non ha stipulato alcun contratto, ed è libero di rinunciare alla fiducia in qualsiasi modo ragionevole. Questo punto di vista trae un certo sostegno dalla questione su cui le parti sono andate in giudizio, cioè che l'imputato ha eseguito la cura così come sapeva come fare, senza questo, che il cavallo è morto per mancanza delle sue cure (cura?). /1/
Ma non si può negare che l'affermazione di un impegno trasmettesse l'idea di una promessa, così come quello di un ingresso nell'attività in corso. Infatti, quest'ultimo elemento è sufficientemente veicolato, forse, Senza esso. Potrebbe essere chiesto, dunque, se la promessa non contasse qualcosa nell'innalzare il dovere di agire. Nella misura in cui ciò comporta la conseguenza che l'azione è stata di fatto per inadempimento contrattuale, la risposta è già stata data, ed è sostenuto da un peso di autorità troppo grande per essere messo in dubbio. /2/ Impegnare il convenuto con un contratto, uno strumento sotto sigillo era essenziale. Come è stato mostrato, già, anche l'antica sfera del debito era stata limitata da questa esigenza, e al tempo di Edoardo III. era necessario un atto anche per vincolare un fideiussore. Era quindi a fortiori introdurre una responsabilità su promesse non rispettate dall'antica legge. Tuttavia, il suggerimento è stato fatto in anticipo, che un'azione sul caso per danno da negligenza, questo è, per omissione di adeguate precauzioni, adducendo un impegno a titolo di incentivo, era infatti un atto contrattuale.
Cinque anni dopo l'azione per negligenza nella cura di un cavallo, che è stato affermato, è stata intentata un'azione /1/ in forma contro un chirurgo, sostenendo di essersi impegnato a curare la mano dell'attore, e che per sua negligenza la mano fu mutilata. C'era, però, questa differenza, che è stato affermato che la mano dell'attore era stata ferita da un T.B. E quindi è apparso che, per quanto il cattivo trattamento possa aver aggravato le cose, la mutilazione era propriamente attribuibile a T.B., e che l'attore aveva un'azione contro di lui. Ciò potrebbe aver portato l'imputato ad adottare il corso che ha fatto, perché si sentiva incerto se qualsiasi atto illecito avrebbe mentito. Ha contestato l'impegno, supponendo che ciò sia essenziale per la causa dell'attore, e poi ha obiettato che dall'atto non risultava il luogo dell'impresa, e quindi era cattivo, perché non mostrava donde l'inchiesta dovesse essere chiamata a parlare su quel punto. L'atto è stato giudicato male per questo motivo, il che sembra che il tribunale abbia approvato il punto di vista dell'imputato. Infatti, uno dei giudici lo definì un atto di patto, e detto questo “di necessità era manutenibile senza specialità, perché per una cosa così piccola un uomo non può sempre avere un impiegato a portata di mano per scrivere un atto” (pur faire in particolare). Allo stesso tempo i casi precedenti che [282] sono stati citati sono stati citati e citati, ed è evidente che la corte non era disposta ad andare oltre, o ritenere che l'azione possa essere mantenuta nel merito al di là dell'eccezione tecnica. In un altro contesto sembra aver considerato l'azione dal punto di vista della trasgressione. /1/
Qualunque sia la domanda che questo caso può suggerire, la classe di azioni che presupponeva un impegno da parte del convenuto ha continuato a essere trattata come azioni illecite per molto tempo dopo Edoardo III. La responsabilità era limitata ai danni a persone o cose derivanti dopo l'inizio del rapporto di lavoro da parte del convenuto. E fu soprattutto per ragionamento tratto dalla legge dell'illecito che fu poi prorogato, come si vedrà.
All'inizio del regno di Enrico VI. probabilmente era ancora la legge che l'azione non avrebbe mentito per un semplice mancato mantenimento di una promessa. /2/ Ma era stato più volte suggerito, come è stato mostrato, che sarebbe altrimenti se l'omissione o la negligenza si verificassero nel corso della prestazione, e la condotta dell'imputato era stata seguita da danno fisico. /3/ Questo suggerimento prese la sua forma più sorprendente nei primi anni di Enrico VI., quando è stato messo il caso del falegname che ha lasciato un buco nel tetto. /4/ Quando i tribunali erano arrivati a questo punto, era facile fare un passo avanti, e per consentire lo stesso effetto a un'omissione in qualsiasi fase, seguito da danni simili.
Qual è la differenza in linea di principio, è stato chiesto, pochi anni dopo, /1/ tra i casi in cui è ammesso che l'azione si troverà, e quella di un fabbro che si impegna a ferrare un cavallo e non lo fa, per questo motivo il cavallo diventa zoppo,—o quella di un avvocato, chi si impegna a sostenere il tuo caso, e, dopo avervi indotto così a fare affidamento su di lui, trascura di essere presente, così da perderlo? Si diceva che nei casi precedenti il dovere fosse dipendente o accessorio al patto, e quello, se l'azione ricade sulla materia accessoria, mentirebbe sul preside. /2/ Si è ritenuto con demurre che un'azione avrebbe mentito per non aver procurato alcune scarcerazioni che l'imputato si era impegnato per ottenere.
Cinque anni dopo un altro caso /3/ salì, che era molto simile a quella del maniscalco durante il regno di Edoardo III. È stato affermato che l'imputato si è impegnato a curare il cavallo dell'attore, e applicò la medicina con tanta negligenza che il cavallo morì. In questo, come nel caso precedente, la questione è stata presa sul presupposto. E ora la differenza tra un'omissione e un atto era chiaramente indicata, la dichiarazione è stata ritenuta non significare necessariamente qualcosa di più di un'omissione, e si diceva che senza l'impegno il convenuto non avrebbe avuto alcun obbligo di agire. Quindi l'accusa della promessa dell'imputato era materiale, e un problema potrebbe essere affrontato correttamente.
Questa decisione separava nettamente dalla massa delle azioni sul caso una classe speciale derivante da una promessa come fonte dell'obbligazione del convenuto, ed era solo questione di tempo perché quella classe diventasse una nuova e distinta azione contrattuale. Se questo cambiamento fosse avvenuto in una volta, la dottrina della considerazione, che fu definitivamente enunciato per la prima volta all'incirca nello stesso periodo, sarebbe stato senza dubbio applicato, e per l'impresa sarebbe stato richiesto un quid pro quo. /1/ Ma la nozione di illecito non fu subito abbandonata. La legge fu stabilita all'inizio del regno di Enrico VII., secondo le precedenti decisioni, e si diceva che l'azione non avrebbe mentito per il mancato mantenimento di una promessa, ma solo per negligenza dopo che il convenuto aveva assunto il suo impegno. /2/
Nella misura in cui l'azione non ha superato i veri limiti dell'illecito, era irrilevante se ci fosse un corrispettivo per l'impegno o meno. Ma quando è stato commesso l'errore di supporre che tutti i casi, se illeciti corretti o meno, in cui è stato fatto un presupposto, erano ugualmente fondati sulla promessa, si pensava naturalmente che seguisse una delle due conclusioni errate. O non presumeva di aver bisogno di qualcosa per cosa, /3/ come non c'era chiaramente nessuno nei precedenti più antichi, (sono casi di puro illecito,) oppure quei precedenti erano sbagliati, e in ogni caso dovrebbe essere addotto un quid pro quo. È stato a lungo riconosciuto con più o meno comprensione del vero limite, Quello, nei casi in cui l'essenza dell'azione era un danno colposo alla proprietà, una considerazione non era necessaria. /4/ E ci sono alcune tracce dell'idea che fosse sempre superfluo, fino a Carlo I.
In un caso di quel regno, l'imputato ha mantenuto un avvocato per agire in una causa per una terza persona, e promise di pagargli tutte le sue tasse e spese. L'avvocato ha reso il servizio, e poi portato debito. È stato obiettato che il debito non mentiva, perché non c'era contratto tra le parti, e l'imputato non aveva alcun quid pro quo. La corte ha accolto l'argomentazione, e ha detto che non c'era alcun contratto o considerazione per fondare questa azione, ma che l'attore avrebbe potuto citare in giudizio in presunzione. /1/
Era, forse, il persistere di questa idea, e la nozione spesso ripetuta che un presupposto non fosse un contratto, /2/ a cui era attribuibile una teoria della considerazione più allargata di quella che prevaleva nel debito. È stato stabilito che l'assunzione avrebbe mentito per una mera omissione o inadempienza. I casi che sono stati menzionati del regno di Enrico VI. furono seguiti da altri negli ultimi anni di Enrico VII., /3/ e non fu mai più messo in dubbio. Un'azione per una tale causa era chiaramente per una violazione della promessa, come era stato riconosciuto dal tempo di Edoardo III. Se è così, era necessaria una considerazione. /4/ Nonostante i capricci occasionali, anche questo era stato risolto o dato per scontato in molti casi ai tempi della regina Elisabetta. Ma l'origine bastarda dell'azione che ha fatto sorgere il dubbio fino a che punto fosse necessaria una qualsiasi considerazione, ha consentito di ritenere sufficienti le considerazioni che erano state indebitate.
Un'altra circostanza potrebbe non essere stata priva di influenza. Sembrerebbe quello, nel periodo in cui ha assunto [286] stava appena crescendo nelle sue piene proporzioni, c'era qualche piccola inclinazione a identificare la considerazione con la causa romana, preso nella sua accezione più ampia. La parola “causa” fu usato per considerazione nei primi anni di Elisabetta, con riferimento a un patto di sequestro agli usi. /1/ Era usato nello stesso senso nell'azione dell'assunzione. /2/ Nell'ultimo rapporto citato, sebbene il caso principale stabilisse solo una dottrina che sarebbe stata seguita oggi, è stato anche affermato un caso anonimo che è stato interpretato nel senso che un corrispettivo eseguito è stato fornito su richiesta, ma senza alcuna promessa di alcun tipo, sosterrebbe una successiva promessa di pagarlo. /3/ A partire da questa autorità e dalla parola “causa,” si giunse presto alla conclusione che c'era una grande differenza tra un contratto e un'assunzione; e quello, mentre nei contratti “tutto ciò che è necessario deve concorrere e riunirsi, cioè. la considerazione di una parte, e la vendita o la promessa dall'altra parte,… mantenere un'azione su un presupposto, lo stesso non è richiesto, poiché è sufficiente che vi sia una causa commovente o un precedente di considerazione; per quale causa o considerazione è stata fatta la promessa.” /4/
così, dove il convenuto ha ritenuto che l'attore fosse a sua zia a dieci scellini a settimana, si riteneva che l'ipotesi avrebbe mentito, perché il servizio, anche se non vantaggioso per l'imputato, era un'accusa o un danno per l'attore. /1/ Le vecchie domande sono state riformulate, e opinioni che erano molto vicine a prevalere in debito sotto Enrico VI., prevalse in assunzione sotto Elisabetta e Giacomo.
Un garante potrebbe essere citato in giudizio in presunzione, sebbene avesse cessato di essere responsabile in debito. /2/ C'era lo stesso rimedio su una promessa in considerazione che l'attore avrebbe sposato la figlia dell'imputato. /3/ L'illusione che l'assunzione così estesa non significasse contratto, non poteva essere mantenuto. In vista di questa ammissione e degli antichi precedenti, la legge oscillò per un certo tempo nella direzione della ricompensa come vera essenza della considerazione. /4/ Ma l'altro punto di vista ha prevalso, e quindi, infatti, apportato una modifica al diritto sostanziale. Un semplice contratto, essere riconosciuto vincolante dai tribunali di Enrico VI., doveva essere basato su un vantaggio per il debitore; ora una promessa potrebbe essere fatta rispettare in considerazione di un danno per il promesso. Ma nel vero spirito arcaico la dottrina non era separata né distinta dal rimedio che la introduceva, e così il debito nei tempi moderni ha presentato l'aspetto alterato di un dovere limitato ai casi in cui il corrispettivo era di una specie speciale.
Le successive fortune dell'assunzione possono essere raccontate brevemente. Ha introdotto contratti bilaterali, perché una promessa era un danno, e quindi considerazione sufficiente per un'altra promessa. Ha soppiantato il debito, perché l'esistenza dell'obbligo di pagamento era una considerazione sufficiente per una promessa di pagamento, o meglio perché, prima che fosse richiesta una considerazione, e non appena l'assunzione mentirebbe per un'inadempienza, questa azione è stata utilizzata per evitare la scommessa legale dell'imputato. Ha notevolmente esteso il numero di contratti perseguibili, che in precedenza era stato limitato a debiti e patti, mentre quasi tutte le promesse potrebbero essere citate in giudizio; e ha introdotto una teoria che ha avuto grande influenza sul diritto moderno,—che tutte le passività di un depositario sono fondate sul contratto. /1/ Se l'importanza data in tal modo al contratto come fondamento dei diritti e dei doveri legali avesse qualcosa a che fare con l'analoga importanza che presto acquisì nella speculazione politica, è fuori dalla mia provincia indagare.
